
Nei primi giorni di settembre 2023 si è svolta la finale del Premio Scenario, con la partecipazione di 12 giovani formazioni artistiche impegnate a presentare i loro progetti di teatro. In questa occasione è stato rinnovato per la sua quarta edizione il “tavolo critico” di osservatori “speciali” che hanno seguito tutti i lavori e alla fine hanno scritto una propria riflessione. Questo che segue è il mio contributo al termine del tavolo critico di Scenario.
I giovani artisti e le giovani artiste hanno portato sulla scena della finale del Premio Scenario le inquietudini comuni a un sentimento generazionale planetario, scandito dal timore dell’assenza di futuro, in cui confluiscono i macigni della pandemia, della guerra, dell’emergenza ambientale, della crisi economica e sociale… Eppure, il pessimismo cosmico racchiuso nello slogan no future (che peraltro rappresenta da almeno mezzo secolo tutte le ondate delle varie nuove adolescenze) ha lasciato posto a Scenario a una ricchezza di discorsi e posizioni che raccontano (anche) altro, mostrando strade più complesse di riflessione, compassione, resistenza. In verità la sensazione di un sentimento comune di depressione, assenza di prospettive, sfiducia nel futuro era presente in grande quantità nel complesso dei progetti presentati alle due tappe semifinali, che si sono svolte a Roma e Piacenza. Ma la selezione che ha individuato i 12 progetti teatrali finalisti a Bologna ha offerto un ventaglio meno prevedibile e forse più aderente alla complessità di una generazione che, invece, ha la forza di reazione, la capacità di visione, e soprattutto l’opportunità di affrontare dubbi e fragilità per opporre una (a tratti disperata) vitalità. Il teatro diventa così luogo di testimonianza, atto d’accusa o strumento per lenire il dolore, ma l’energia espressa non ha mai le paventate caratteristiche del ripiegamento intimista o della resa: sotto storie anche dure, problematiche, sofferenti, cupe, si esprimono voci che a quella cupezza non vogliono arrendersi. La cronaca delle finali del Premio Scenario è la cronaca di una resa scongiurata di fronte alle avversità della vita e della storia.
A questo punto si aprirebbe la questione su come questo avvenga, data la grande ricchezza di linguaggi e di idee di teatro che questi giovani artisti under 35 esprimono, anche in questo caso evitando l’omologazione crescente (in particolare dei linguaggi iper-tecnologici e della iper-performatività). Acquista, così, un senso più profondo il concetto di nuovi linguaggi che sta alla base del Premio. I linguaggi nuovi esplorati dai giovani artisti di questa edizione si presentano infatti come linguaggi ‘antichi’ che tuttavia acquistano nuovi o differenti utilizzi, meccanismi, espressioni in funzione delle urgenze nuove che vengono espresse. La nuova generazione del teatro, insomma, fa leva su quel linguaggio arcaico che è il teatro e sui suoi strumenti più propri e tradizionali per affermare la propria (r)esistenza e ridefinire quello stesso linguaggio e quegli stessi strumenti in modo originale e dunque nuovo, per proiettarsi, sia pure con trepidante inquietudine, in un ok future da scoprire. Ed è tutta questione di giochi, maschere, intrecci e, ovviamente, di parole, voci e corpi.
Giochi
Gioco come meccanismo di comprensione della difficoltà del reale, come sua rappresentazione ed esorcismo. Gioco teatrale che dialoga con i giochi infantili e i giochi di società, che diverte e inquieta. Almeno due progetti fanno riferimento al gioco come dispositivo scenico, trovando in esso la chiave di una riflessione sociale e politica, e al tempo stesso una modalità squisitamente teatrale, che ancora una volta ci ricorda la comune radice di gioco e teatro, ossia play, jeu, Spiel. La cosa interessante è che entrambi i progetti, pur nella profonda diversità di strumenti, temi e obiettivi, utilizzano gli strumenti di una giocosità anti-moderna e pre-digitale (perfino quando uno dei due si avventura a sondare le ‘meraviglie’ di ChatGPT) per affrontare questioni di stringente contemporaneità, con analoghi effetti di stuzzicante spaesamento, dove in definitiva il gioco è utilizzato per smascherare gli inganni.

Il tema di Banned – Tutorial per Boomer di Marco Montecatino è il confronto con i social media: il protagonista è uno sprovveduto nei confronti della comunicazione digitale, istruito da una voce esterna e invitato ad addentrarsi nel favoloso mondo degli algoritmi, dove incontra tre tipologie di comportamento da social – il complottismo, il tutorial, gli incontri erotici – fino all’abdicazione della propria identità a favore di un avatar che prende il suo posto. La chiave ludica è insita nei social network stessi, la cui seduzione giocosa ha contribuito a determinarne il successo, e qui si materializza nella scelta di un linguaggio altrettanto ludico che si sottrae alla tecnologia per recuperare, per vivace contrasto, un magazzino di oggetti teatralmente vintage: costumi, colori, oggetti gonfiabili come in una piscina per bambini, danno forma allusiva a un mondo digitale, che di fatto è assente dalla scena. Perfino la scelta drammaturgica di utilizzare ChatGPT e l’intelligenza artificiale per coadiuvare la scrittura non viene dichiarata, e anzi dimostra – secondo la testimonianza dell’autore – la sua inconsistenza e banalità, diventando non determinante. E così, il teatro sottrae dal digitale la sua fascinazione tecnologica, sbugiardandolo (il re/il digitale è nudo) con l’assimilazione delle sue magie a vecchi trucchi e oggetti sciocchi e banali, che prendono forma solo in quanto pura aria gonfiata. Sfida sottilissima, con il rischio della banalizzazione del tema e del facile didascalismo dell’operazione, che tuttavia impone momenti di riflessione che l’uso di linguaggi realmente tecnologici forse non avrebbe consentito: Montecatino sceglie una strada apparentemente dimessa, smontando la fascinazione trendy e andando (forse più speditamente) a individuare cosa si cela oltre lo schermo digitale: la sostanziale solitudine della persona, in cui la ricchezza di stimoli e di contatti si manifesta solo nell’inconsistente parco giochi in cui chiunque – se solo aprisse gli occhi – si scoprirebbe inerme, boomer ontologico di fronte alla disumanizzazione che lo circonda, come un Dante impacciato in un viaggio fintamente ultraterreno che si rivela essere solo una baracconata.

Sulla baracconata gioca apertamente Pinocchio mangia spaghetti alla bolognese del Collettivo Crisi Collettiva, che si presenta come “transfemminista, antifascista, anticapitalista e pure antiteatralista”. Obiettivo del progetto è la denuncia della condizione di precarietà dello studente universitario a Bologna, che comprende il sistema ansiogeno di una meritocrazia performante e competitiva, la crisi degli alloggi, il suicidio giovanile, l’assenza di prospettive. Da Bologna, che si rivela con i suoi contorni urbanistici sul tappeto di scena, con i suoi monumenti rievocati in tableaux vivants e con l’ascolto delle testimonianze orali, raccolte in un approfondito percorso laboratoriale, la questione si allarga dunque ben oltre i confini cittadini, anche grazie all’uso di un doppio filtro narrrativo: quello di Pinocchio, assimilato alla figura dello studente, e quello del Monòpoli, icona ludica del capitalismo, che dissemina la strada del giocatore di probabilità e imprevisti. La strampalata via crucis del burattino e l’accidentata via aurea del capitalista in erba assorbono con la loro potenza evocativa le difficoltà generazionali di un giovane senza voce. E così, la spinta autobiografica dei giovani artisti millennials genera un’affabulazione collettiva, che trasfigura la ricognizione fenomenologica in protesta e rivendicazione. Con tutte le (feconde) ambiguità del caso. Bologna è presentata al tempo stesso nei termini di un affascinante polo di attrazione e di affermazione di sé, come emerge dalle testimonianze, ma anche nei termini di un luogo respingente: obiettivo del Collettivo non è probabilmente l’analisi delle ragioni e delle responsabilità, che si immaginano altrettanto complesse e ambigue, ma la denuncia di un disagio, la cui insostenibilità è filtrata dalla vivacità giocosa, dalla ricca oggettistica, dal meccanismo brillante di un Monòpoli pinocchiesco che avvicina il tema con un chiarissimo simbolismo, forse rischiando di tralasciare i gangli dell’analisi e della problematicità.
Maschere
Altro elemento antico del teatro, ripreso in diverso modo da due progetti, è la maschera, o meglio l’idea di una riduzione del personaggio a identità fissa, caratterizzazione, che aiuta a portare in primo piano non tanto le psicologie quanto le dinamiche relazionali. La maschera che cela il viso dell’attore è un copricapo o un trucco invadente, e immediatamente scatena nello spettatore la vertigine della ritualità teatrale arcaica, dove la maschera attinge al subconscio e all’ultrasensibile, trasformando il fragile performer in presenza magica, demoniaca, ultraterrena o infera, sicuramente irrealistica e pur sempre specchio deformato e rivelatore della realtà. In questi due progetti, entrambi proposti da compagnie napoletane (una coincidenza, ma come evitare di sottolinearlo pensando alla vertiginosa tradizione della maschera del teatro napoletano?), il mascheramento ha dunque il senso e la funzione dello svelamento.

Sono tutti personaggi con la maschera quelli di Allontanarsi dalla linea gialla di La Cumana, o forse proiezioni di un immaginario malato o di un rimosso dal profondo; tutti con la calottina in lycra che annulla il viso o con teste animali allusive, come la gallina che vuole essere gallo o l’orso che compare sul finale dei primi 20 minuti e che, secondo il progetto, dovrà imprimere una svolta radicale nel prosieguo della vicenda. Vicenda che è quella di un villaggio dimenticato, abitato da figure residuali e perdenti, abbandonato dalle speranze ma non da persone che si agitano inutilmente in desideri infondati o recriminazioni reiterate, attraversato da una ferrovia che porta un treno inutilizzato, racchiuso in quella linea gialla che è gabbia e soglia al tempo stesso. Qui le maschere trasformano le figure in caratteri, ma soprattutto ne annullano l’umanità, contribuendo a costruire un mondo distorto e distopico, parlato da un linguaggio assurdo e grottesco, dipinto da una visionarietà surreale e infantile (il luna park e il trenino sono giocattoli di cartone), in cui le azioni sono quelle di un realismo più stregato che magico, dove i classici tipi da bar sembrano avvoltoi inermi in attesa di un cataclisma che non verrà o dove la ragazza, forse abusata, trascina la gravidanza per anni pur di non partorire. Le maschere ci spingono al confronto con un mondo quasi infero, che tuttavia rappresenta lo specchio deformato delle nostre solitudini e paralisi. Quelle calottine lycra sono tutt’altro che pulite e omologate: ciascuna porta in evidenza segni che distorcono le fattezze, deformandole sottilmente in smorfie che denunciano l’accumularsi del tempo e della sofferenza su ciascuno. La storia subirà, a quanto spiegato dagli artisti, uno scarto significativo con il classico arrivo dello straniero, una ‘bestia’, che sarà al tempo stesso angelo dell’apocalisse (ambientale?) e capro espiatorio di una società incapace di confrontarsi con le proprie responsabilità: scarto che rischia di spostare troppo altrove l’impianto già così intenso, omogeneo e preciso dello studio mostrato in finale, inserendo forse troppi elementi ad alta densità per un solo lavoro. Che, nell’unitarietà della proposta scenica vista in finale, ha invece una ricchezza narrativa e visionaria tale da sostenere il suo completamento senza ulteriori aggiunte.

È un altro tipo di maschere quello proposto invece da RI.TE.NA. Teatro con ’E Zzimmare. Dal microcosmo marcescente della fiaba corrotta del precedente progetto si passa a un altro microcosmo altrettanto marcio e corrotto, che si rifà semmai all’antropologia della sceneggiata napoletana, filtrata dalla lezione della drammaturgia partenopea da Ruccello in giù, non senza quella musicalità linguistica che qui si alimenta anche di un’attenta scrittura scandita da rime e assonanze. L’ambiente è quello di una famiglia disfunzionale (il titolo riporta il cognome), di personaggi disadattati, borderline, che oscillano tra un turgido iperrealismo e una vivace vis caricaturale: maschere, insomma, senza bisogno di indossarne di finte, perché in fin dei conti ciascuno è di per sé maschera, post-macchietta, incapace di uscire da sé e dal buco sociale ed esistenziale in cui è conficcato: il cocainomane ex carcerato, la marchettara che va con tutti, la travestita, lo psicolabile e la sorella maggiore che decide di avvelenare tutti per porre fine a un’eredità genetica compromessa: muoia, insomma, Sansone con i filistei per azzerare la deriva malsana. Ma, anche qui, il mascheramento grottesco – che pure è suggerito da un sovraccarico di costumi e trucchi – punta a svelare le dinamiche assimilatrici o prevaricatrici di ogni famiglia: difficile rispecchiarsi in questi mostri, difficile non rispecchiarsi nella struttura delle loro schermaglie familistiche e ricattatorie. Eppure, come in tutte le stragi familiari che si rispettino, da Edipo ad Amleto, l’orizzonte riserva una salvezza, peraltro tutt’altro che certa. L’eccidio totale, infatti, risparmia il feto portato in grembo dalla sorella più giovane, e qui si aprono le possibilità o impossibilità: marchiato anch’egli dalla tara genetica e ambientale, oppure salvatore senza radici e capace di iniziare una nuova età dell’oro? Nel progetto drammaturgico il bambino nascituro sarà idealmente affidato alla ‘cura’ del pubblico, estendendo così la questione a un altro livello: tocca alla società farsi carico di ogni individuo per strapparlo da un destino già scritto di sofferenza e abiezione? Insomma, il bizzarro ritratto di una ‘umanità’ al limite (oltre i limiti) diventa arditamente un apologo sulla responsabilità sociale.
Intrecci
Il teatro è relazione: relazione in scena e relazione tra la scena e chi assiste. Due progetti scelgono di esplorare le dinamiche relazionali – pur presenti anche negli altri – in modo più spinto, giocando su intrecci plurimi, esplorando cioè una pluralità (collettività) anomala, a suo modo artificiosa, con traiettorie drammaturgiche e comunicative che ridisegnano relazioni sempre diverse e mutevoli. Sono reticolati fitti di parole e azioni, che nella ricchezza di spunti e proposte rendono evidente la paralisi in cui vivono i personaggi e i mondi che essi rappresentano, che si tratti di una paralisi esistenzial-generazionale, come nel primo, o di una paralisi creativa che si allarga allo stallo di una realtà percepita solo per stereotipi.

La crisi come stato permanente, che aleggia su questa generazione, ha la sua enunciazione più diretta in Permacrisis di Sea Dogs, che nel titolo riprende la parola dell’anno 2022 secondo il dizionario britannico Collins. In scena, quattro giovani sull’orlo di una crisi di nervi, punto nevrotico di assorbimento delle crisi che attanagliano il pianeta (la presenza abnorme di bottiglie d’acqua di plastica ne è una spia) e che attraversano le loro vite così normali, quasi banali, svolte nelle ritualità quotidiane pinteriane di chiacchiere alle soglie di una festività che li vede riuniti. La desolazione domestica scandisce i dialoghi sbocconcellati, le azioni inconcludenti (bere bicchieroni d’acqua, spazzare inutilmente per terra, sdraiarsi o sbriciolare a morsi un pandoro), mentre scenette di ordinaria e paralizzata inconsistenza si alternano a rapidi momenti di buio totale in cui si scatena un’assordante musica metal, come se l’urlo vitale e sconvolgente potesse riecheggiare solo nei vuoti sospesi in cui tutto scompare. La stessa sintassi frammentaria, sviluppata nei quadretti e nei bui come una collezione di sketch o ritratti di una galleria dell’alienazione odierna, rende conto della fragile instabilità di queste identità e soprattutto delle loro relazioni, che alla verità sostituiscono la superficialità di discorsi routinari che nascondono la depressione individuale e lo stallo comunicativo e di senso di una socialità in crisi. Come in altri progetti, sembra qui prevalere la necessità di una testimonianza del disagio piuttosto che la spinta a penetrare nelle sue motivazioni: se è l’epoca della permacrisi, se è la generazione dell’impotenza, la stessa ricerca di un senso a quanto accade pare superflua, e quel che resta sembra essere solo il ripetersi di ritualità sconnesse e inette.

Questa sensazione aleggia anche in anonimasequestri di Leonardo Tomasi, che tuttavia impregna il vuoto delle relazioni e dello scambio comunicativo, lo stallo dell’individuo e di una generazione, e la crisi diffusa, con un’idea folgorante e acutamente ironica, anzi un doppio dispositivo concettuale e teatrale, che ha portato il progetto ad aggiudicarsi il Premio Scenario 2023. Da una parte Tomasi fa riverberare il senso di impotenza individuale nel senso di frustrazione collettiva di una terra come la Sardegna, appiattita nella percezione esterna da stereotipi, pregiudizi e presunzioni; dall’altra, trasferisce la crisi delle relazioni in una sorta di crisi della rappresentazione (e dunque della realtà rappresentata), proponendo un progetto di spettacolo che racconta del provino di due aspiranti attori da parte di un regista per un film sui sequestri di persona. Nello studio presentato in finale, vediamo attorno a un tavolo (che nello spettacolo portato a termine dovrebbe raccogliere anche il pubblico, col rischio, però, di indebolire la potenza dell’idea a favore di un superfluo coinvolgimento dello spettatore) il regista con tanto di telecamera che fa il provino ai due, mentre un quarto personaggio è seduto, immobile e muto, legato e con un sacco sulla testa: l’ostaggio sequestrato, appunto. La relazione fra i tre (e la non relazione con il quarto) vive, anche in questo caso, di discorsi superficiali e inconsistenti, che hanno però, argutamente, nella Sardegna e nella sardità il loro centro: e così, è tutto uno scoppiettante carosello di battute e allusioni, che chiamano in causa i luoghi comuni, i personaggi famosi, il folklore, il teatro sardo (col tormentone sul Macbettu di Alessandro Serra), perfino i gesti (a un certo punto si portano una mano all’orecchio come nel canto a tenore, ma qui è solo per mimare il telefonino), in un continuo rilanciare a marrano, la sfida da cui nessun sardo può tirarsi indietro. Il pericolo di scivolare nella pura comicità è in agguato, ma lo sviluppo autoironico delle allusioni rende conto molto bene della questione sarda in termini non meramente buffi, ma facendo emergere la complessità della percezione della Sardegna dal ‘continente’ e viceversa, diventando così un discorso più generale: sull’insularità, sull’identità eccentrica, sulla marginalità. Marginalità dei luoghi, che a sua volta si riverbera nella marginalità degli artisti: il regista, gli attori e il senso stesso del loro esserci e del loro fare. I quattro personaggi in scena, nella loro sostanziale incomunicabilità – o comunicabilità meramente funzionale –, sono figure forti, che lo sviluppo del progetto può arricchire: la dimensione tragicomica del regista della sardità che non sa parlare sardo fa il paio con la coppia para-clownesca e para-beckettiana dei due attori, quelli sì genuinamente sardi, ma altrettanto genuinamente impotenti, per non parlare del quarto incomodo, il rapito, che con la sua presenza-assenza getta una luce grottescamente sinistra sul tutto, come una chiave di volta che ribalta in continuazione i piani e le interpretazioni. E così il rapito è la materializzazione della passività dello spettatore, gli attori sono essi stessi i sequestrati (dal regista e da ogni forma ricattatoria del mondo dell’arte e del lavoro tout court), e infine il regista è la proiezione di chiunque reclami un attivismo facilmente naufragato di fronte all’incapacità o all’inadeguatezza dei mezzi. Il progetto drammaturgico, come spiegato dall’autore, dovrebbe poi svilupparsi nel senso di un vero rapimento che innesta la realtà sulla finzione, a moltiplicare ulteriormente i piani, sperando che questa evoluzione riesca a mantenere il prezioso equilibrio instabile e la leggerezza mostrata in questo studio.
Parole
La magia della parola in teatro sta soprattutto nella sua capacità di veicolare non la realtà, ma la simulazione. L’ambiguità della parola è spesso il motore più forte, innesca l’attraversamento di universi reali che però si sgretolano allo svelamento della loro fallacia. La parola, insomma, è un trabocchetto, soprattutto quando la verità in sé e per sé è il tema del suo dire. Due progetti si confrontano in modo stretto, incalzante, assoluto con la parola, creando architetture di raffinata drammaturgia in entrambi i casi, giocando (in modo eccellente) con gli elementi più precipui della parola stessa: il monologo e il dialogo. E in quel confronto, entrambi svelano come la parola si trasformi in gabbia, muro, depistaggio, simulazione; entrambi mostrando come la finzione parta dalla pietas e dalla volontà di evitare il dolore; entrambi arrivando a ritrovare in quella parola il balsamo ambiguo ma necessario per sopravvivere.

Il flusso verbale e monologante di Pietro Giannini in La costanza della mia vita – Segnalazione speciale del Premio Scenario – è il racconto di un bambino di 9 anni, al centro di fatti e parole troppo importanti e insostenibili: la famiglia divisa e la sorella “trasferita” sono il mondo di affetti complicati di fronte ai quali il piccolo alza le difese dell’immaginazione con l’arma di una parola capace di reggere macigni grazie alla facile agilità della bugia. La parola reinventa il mondo cupo che lo circonda e lo trasforma in fiaba, trascinando il pubblico nell’incanto, grazie anche all’interpretazione dello stesso autore, poco più che ventenne, che con la freschezza del corpo e della voce e la naturalezza naïf del racconto riesce a ipnotizzare e convincere a entrare tutti insieme in un mondo che si può solo immaginare, visto che la scena è totalmente spoglia, con una sola sedia e la luce fissa. Difficile accorgersi dei trabocchetti del testo, disseminato di parole come tracce cifrate che solo nel finale saranno decodificabili e acquisteranno il loro senso reale, quando ormai sarà troppo tardi per lo spettatore risalire alla levità iniziale e invece, insieme a Pietro, a Costanza, alla famiglia, si troverà a scivolare nella tragedia e nel dolore. L’acqua rossa, la pioggia negli occhi, la signora del pongo… sono solo alcuni elementi di una fiaba-schermo, sostenuta da una scrittura ispirata a una intensa poesia del quotidiano, che dona al protagonista bambino una qualità linguistica complessa, in un gioco vorticoso di depistaggi, equivoci, tranelli: perché in quelle parole c’è il bambino di 9 anni e al tempo stesso c’è il giovane che oggi osserva con distanza e partecipazione quel bambino, con emozionante lucidità. Sono parole che riportano alla memoria e al tempo stesso leniscono il dolore, risucchiando a poco a poco il pubblico verso la celebrazione di un rito di reviviscenza attraverso la trasfigurazione di quella stessa memoria nell’affabulazione fantastica. Tocca al pubblico scandire con un timer gli ultimi 5 minuti: pubblico testimone dal potere supremo di scandire il tempo, forse di fermarlo (ma questo non lo sa, non lo immagina, e intanto il tempo scorre…). E così – si scopre proprio in quegli ultimi 5 minuti – ecco che il vero tema sotterraneo è il tempo, quello che scandisce le tappe della vita e della conoscenza del bambino, quello che determina l’imprevedibile sliding door dell’ultimo atto, quello che separa il bambino di 9 anni dall’autore di 22, in una divaricazione che permette a quest’ultimo di osservare il sé infantile e ignaro, con tutto l’amore, la comprensione, la pietà, il sostegno, che se solo si potesse tornare indietro…

Anche per la Compagnia Banicolà è una questione di parole sbagliate, di senno di poi, e di un tornare indietro non più possibile in DUE – Canto di balene per pinguini soli. In questo caso, la costruzione verbale dei depistaggi è un dialogo tra un uomo e una donna: due giovani innamorati, desiderosi di avere un figlio, e bloccati dalla sterilità di lei. Il tema non è però la sterilità, ma ancora una volta la parola non detta che ha fatto credere a lui l’impossibile, scatenando un irrimediabile conflitto sulla doppia ragione, che li divide e forse divide il pubblico: ha ragione lui a non fidarsi più di lei che non gli ha detto una cosa così importante o ha ragione lei nel sostenere che non aveva l’obbligo di rivelare un problema così intimo che non aveva mai inciso sul loro rapporto? In realtà, più di questo tema è la costruzione del testo e dello spettacolo – anche questo collocato in uno spazio vuoto, con sole due sedie – a rappresentare la più importante sfida verbale e concettuale. Il gioco delle simulazioni, del detto e non detto, di racconti, rievocazioni, recriminazioni e amnesie, si trasferisce infatti dalle schermaglie tra i due personaggi a quelle tra l’attore e l’attrice, in un gioco sottile, mentre si presentano al pubblico in una posizione ambigua di interpreti e personaggi al tempo stesso, impegnati a cercare di ricostruire i tasselli della narrazione, (in)consapevolmente pieni di trabocchetti reciproci. Il problema è, insomma, quello della ricostruzione verbale hic et nunc della storia, dove i fatti, già così gravati dagli inganni della parola e del silenzio, esistono o no a seconda della loro enunciazione verbale. In tutto questo, diventa sostanziale la scelta del registro della commedia, che rimanda inevitabilmente ai milioni di brillanti sketch lui-lei che intasano cinema e televisione: la commedia, in questo caso, filtra e ovatta non tanto la tragedia piccolo-borghese della mancata maternità e/o della mancata verità, quanto la difficoltà della metanarrazione, che è poi la difficoltà della ricostruzione storica e ‘oggettiva’ (qui della vita di una coppia, ma altrove…) e, all’estremo, la difficoltà stessa del racconto teatrale e della ricostruzione della sua ‘verità’ e della sua credibilità.
Voci
C’è poi una soglia prima o dopo la parola, ed è la voce, quando portando la parola porta anche il corpo che la sostiene, trasformando questa possibilità in canto, estendendo dunque l’ascolto verso un altro livello di percezione e comprensione. La voce si ripercuote nel corpo di chi ascolta prima che nel cervello, soprattutto se accompagnata dalla musica: di uno strumento, di un oggetto, delle corde vocali stesse. Un progetto di Scenario si ferma sul confine tra la voce e la parola, come un fragile filo di discorso in cui rimbalzano parole, emozioni, rime dialettali e canzoni pop. Un altro si tuffa totalmente nella musica, affrontando la sfida di uno scontro tra la voce recitante, la voce cantante, gli strumenti elettrici ed elettronici. Due voci femminili che esplorano diversamente la fonè, invitando prima di tutto all’ascolto.

In SS16 Debora “Binju” Binci propone un viaggio ideale nella sua regione di origine, lasciata da tempo, le Marche: una sorta di road movie teatrale, a bordo soltanto di un microfono e di una tastiera elettronica, che a tratti accompagna la voce narrante in squarci canori pop, a cominciare da un pezzo di Franco Battiato. La memoria personale e quella collettiva, la cronaca e il paesaggio si combinano in un flusso narrativo dalle reminiscenze tondelliane, che si compone di mini-racconti, ritratti, lampi e divagazioni, tutto sostenuto da una voce pacata, confidenziale, quasi intimista, che di volta in volta si piega e rimodula a seconda dei personaggi incontrati nel percorso, fino a una violenta invettiva: brucino le spiagge, i centri commerciali…! L’atto d’amore per le Marche è anche l’appassionato sforzo di comprensione di una regione che mostra non solo i frammenti di ricordi infantili – come “le” Lego o la storica azienda di strumenti musicali Farfisa – ma anche le crepe di una modernità dai tratti inquietanti, cupi, devastanti, che rivelano una violenta decadenza culturale e sociale, a partire dall’evocazione di un razzismo e fascismo che proprio questa regione ha in alcune occasioni dimostrato, a cominciare dalla vicenda Traini. Debora bambina, la famiglia, l’ambiente, i personaggi caratteristici e i nuovi mostri della modernità: è una solitudine affollata quella dell’attrice che riempie lo spazio vuoto di voci ed evocazioni, invitando il pubblico ad accompagnarla sulla strada statale 16, in un viaggio che è tutt’altro che regionalistico. Le Marche finiscono per presentarsi come uno state of mind, metonimia del nostro Paese: andando a ritroso nei propri luoghi, nei ricordi e nelle emozioni personali, Debora scopre la particolarità di quei luoghi e al tempo stesso la loro universalità. E forse, paradossalmente, è proprio con la dizione dei versi in marchigiano di Franco Scataglini, cioè quanto di più intimamente connesso con il particulare a causa della lingua, che il progetto può fare il grande salto di viaggio universale, cioè grazie alla poesia assoluta di una lingua altra, che suggerisce l’altrove in noi, e che viene sussurrata, enunciata, ‘cantata’ da una voce pronta a spiccare il volo.

Ed è ancora voce, musica, poesia il progetto di Tilia Auser Tre voci, che si è aggiudicato l’altra Segnalazione speciale del Premio Scenario. Qui il punto stesso di partenza è costituito dalla voce, quella delle Tre donne di Sylvia Plath, il radiodramma in versi che esprime i sentimenti di tre personaggi femminili in gravidanza, di fronte rispettivamente alla maternità, a un aborto spontaneo e all’abbandono del neonato: voci di trepidazione, paura, dolore, orgoglio e fragilità. Nel progetto le tre donne sono incarnate da una stessa performer, che passa da uno all’altro dei tre luoghi deputati della scena, con alcuni oggetti (una macchina da scrivere, un registratore, un sacco di terra) e soprattutto microfoni. La voce delle tre donne è una voce amplificata, filtrata, campionata, in flussi verbali (in traduzione apposita) o in brani in inglese cantati da Sara Bertolucci con grande intensità e potenza, quasi richiamando da una parte la voce musicale poetica di una Patti Smith e dall’altra la visceralità testimoniale di una Diamanda Galas. In scena è anche il musicista, Riccardo F. Scuccimarra, che accompagna la via crucis delle tre donne con un tappeto sonoro immersivo, costante, debordante, mentre la stessa performer manipola a vista l’audio. Un concerto-spettacolo-poesia, dove forse in questo studio la musica rischia di sovrastare la parola e la (pur limitata) azione performativa, che vede l’attrice muoversi come in un’installazione d’arte contemporanea, esponendo il proprio corpo e la propria presenza fisica a essere veicolo di poesia, in uno spazio che, costruito a luoghi deputati, ci appare come un rebus da decifrare, o meglio un mistero sacro da osservare nella sua assoluta impenetrabilità. Come poter penetrare, del resto, nel mistero della maternità, o meglio nel sentimento di una donna verso la gravidanza? La risposta di Tilia Auser è estrema, assoluta, lasciata alla poesia, senza ammorbidimenti o ironie: sangue, corpo, vita, morte sono affermati nella loro realtà intrinseca, sublimata da una parola vertiginosa che chiede solo ascolto e contemplazione del mistero. Una scommessa coraggiosa e rischiosa, che esplora l’indicibile attraverso l’unica cosa che può dire il sentimento nella sua purezza: la poesia, la voce, la musica.
Corpi
Se il teatro è corpo (e tutti i progetti presentati, con diverse densità hanno evidenziato un certo lavoro sul e col corpo), il corpo a teatro reclama la sua centralità quando si trasfigura in un rito di possessione che non è semplicemente quello dell’attore che si fa personaggio, ma è quello del performer che si fa attraversare da parole, suoni, immagini e altre identità. Qualcosa che spalanca di fronte allo spettatore la vertigine di una presenza che diventa altro da sé, e si esprime in quanto corpo, muscolarità, vocalità, gesto, movimento. Due progetti hanno in modo molto diverso interpretato la fisicità assoluta del performer solitario, soprattutto nei termini dell’attraversamento e nei termini della cura di una gestualità cifrata, che in un caso si esprime esplicitamente come danza.
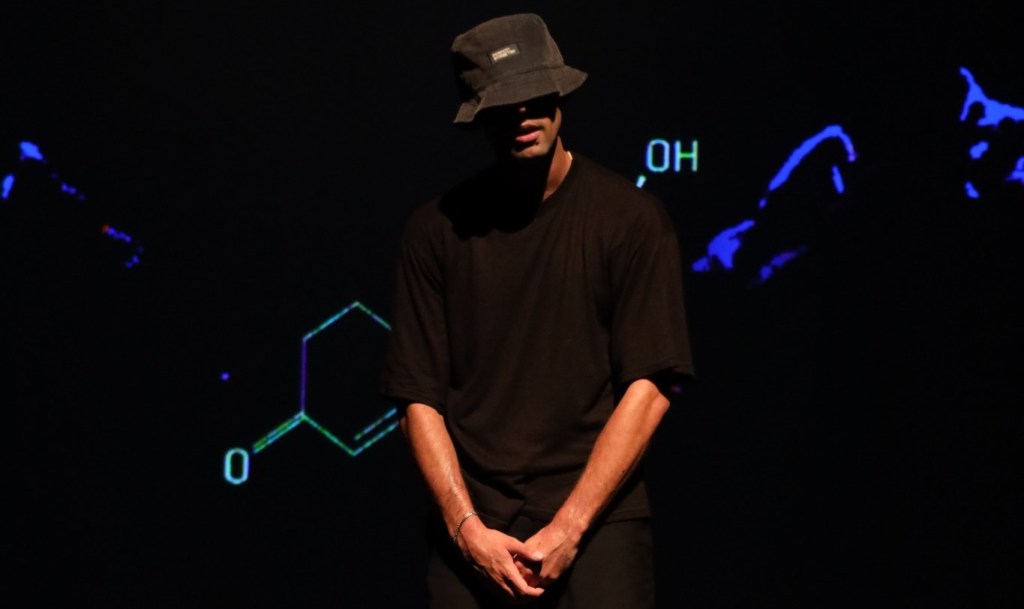
Anche O®A (suoni dal remoto attuale) di FanniBanni’s è strutturato, come Tre voci, con un attore e (in questo caso) un sound designer in scena, in un assolo poetico accompagnato dalla musica. Ma più che un discorso sulla musica e sulla voce, il progetto concepito e incarnato da Rocco Ancarola è una questione di corpo, nel senso della trasfigurazione della fisicità del performer, che viene attraversato da presenze, visioni, parole, mondi. Si tratta di un lavoro profondamente generazionale, che dà voce all’universo giovanile attraverso le sue convenzioni, consuetudini, pratiche. Il linguaggio teatrale stesso è concepito come un’ibridazione di modalità della comunicazione che alla classica forma-monologo intrecciano la slam poetry, il rap, la trap (nel titolo la parola ‘ora’ è scritta nell’alfabeto leet, sviluppato in ambiente internet). Ciascuno di questi linguaggi ‘entra’ nel corpo del performer, lo rimodella e destruttura, insieme al flusso musicale e al flusso visivo, composto da una serie di immagini montate in modo incalzante, proiettate sul fondo della scena, sopra il corpo stesso dell’attore. Il testo attraversa, ritmico e implacabile, alcuni luoghi deputati immateriali dell’esperienza generazionale, come i social media, la Nike, il sesso, la discoteca o la droga, trovando parole e fisicità che rifiutano sia il mimetismo sia il distacco: non c’è fenomenologia o sociologia, non c’è moralismo o paternalismo. C’è, semmai, una trance concettuale che si trasforma in visione, a partire dall’immagine iniziale del performer che recita i suoi versi chinato sulle scarpe Nike, lasciando in vista solo le braccia nude che ‘danzano’ disarticolate, come zampe d’insetto, come un fantasma post-kafkiano o un meme a pixel sgranati. E tuttavia, l’obiettivo è preciso: la messa in evidenza della deriva ideale di fasce di popolazione giovanile che inseguendo l’affermazione della propria identità, con un afflato eroico maledetto da nuovi Baal (in senso brechtiano), si ritrovano a calcare le strade deleterie del sessismo e dell’individualismo, dell’accettazione di una visione capitalista e ultramaterialista, poveri figli spuri nel dopostoria dell’omologazione consumista (in senso pasoliniano).

È invece un viaggio tutto intimo Luisa di Valentina Dal Mas, che ha vinto il Premio Scenario Periferie. Un progetto profondamente umanistico, che trasforma il dialogo dell’artista con una donna ospite in una casa di cura in un mettere la fisicità dell’una a disposizione dell’altra. Valentina assume su di sé, attraverso il suo corpo di danzatrice, il corpo fragile di Luisa: i gesti, le espressioni del viso, i tic, le pantomime, le deformazioni, le ossessioni. Non mimesi, ma coesistenza del corpo fantasmatico (e alla fine mitico) di Luisa nel corpo attraversato (e alla fine rituale) di Valentina, che accompagna così Luisa in una danza composta dai gesti quotidiani attentamente osservati e minuziosamente replicati e reinventati in una coreografia che vuole essere ritratto esteriore e interiore al tempo stesso. Le parole di Luisa, che si ascoltano a tratti e parlano di cose quotidiane e di incontri affettivi, precipitano in fisicità, trapassando il corpo di Valentina, in un passo a due che non è possessione ma dialogo di muscoli, nervi, pelle e carne: lo spettatore vede Luisa in Valentina e vede Valentina che si rispecchia in Luisa, la osserva e la fa rivivere, la accarezza e la innalza, in un atto d’amore dichiarato all’inizio con le uniche parole dette dalla danzatrice: “mi sono innamorata di Luisa”. Nello studio presentato in finale, per tre quarti del tempo la danzatrice è seduta in primo piano: la danza si sviluppa nella fissità della posizione, che sostiene un’estrema dinamicità del corpo, quasi in un rapporto teso e radicale tra la gabbia del luogo da cui non poter uscire e la vitalità che si esprime in ogni singolo punto del viso, degli arti, del busto, delle mani che a tratti percuotono il corpo segnando il ritmo, diventando musica. La sedia, con accanto una rosa, è casa, è mondo, è vita: tutte gabbie e al contempo spazi immensi di possibilità. Poi, d’improvviso, la fissità si spezza, lo spazio si allarga, viene sfondato, il corpo di Valentina invade l’intera scena, trascinando con sé Luisa e lo spettatore in un movimento quasi vertiginoso, come se l’abisso si fosse spalancato con la musica di Vivaldi che accoglie le evoluzioni danzate, spingendo l’emozione e la commozione al massimo, facendo scoprire in ognuno l’ebbrezza di un corpo fragile e forse immobilizzato (perlomeno idealmente se non fisicamente) che ora scopre lo spazio, l’abisso e il paradiso, un sé altro e un altrove fuori da sé. Nel compimento del progetto c’è l’ipotesi di terminare con Valentina-Luisa che solleva la rosa come nel quadro di Delacroix La Libertà che guida il popolo, diventando una portabandiera delle fragilità, anzi della forza trascinante delle fragilità.
E in questo gesto tutti i progetti finalisti sembrano raccogliersi. Nella rosa alzata da Luisa, oltre la sensazione interiore del no future. Affermando, con tutta la loro fragilità e forza: ok future!
CREDITI
Collettivo Crisi Collettiva, Pinocchio mangia spaghetti alla bolognese; di e con Sofia Boschi, Filippo Gonnella, Elia Montanari, Noemi Pittalà, Beatrice Zanin. Compagnia Banicolà, DUE – Canto di balene per pinguini soli; regia e drammaturgia Mattia Lauro, Antonio Basile; con Mattia Lauro, Claudia Nicolazzo. Debora “Binjiu” Binci, SS16; di e con Debora “Binjiu” Binci. Fannibanni’s, O®A (suoni dal remoto attuale); concept, regia e drammaturgia Rocco Ancarola; con Rocco Ancarola, Gabriele Anzaldi; sound design Gabriele Anzaldi, Alessio Calabrese; dramaturg Nicoletta Nobile; assistenza alla regia Giovanni Di Capua, Nicoletta Nobile; assistenza tecnica Giovanni Di Capua; video/visual Rocco Ancarola, Jacopo De Maio, Giovanni Di Capua. La Cumana, Allontanarsi dalla linea gialla; regia e drammaturgia Luigi Bignone, Marica Nicolai; con Luigi Bignone, Martina Carpino, Marica Nicolai, Gianluca Vesce; aiuto regia Giampiero De Concilio; progetto visivo Sebastiano Cautiero, Tommaso Vitiello; costumi Rachele Nuzzo. Leonardo Tomasi, anonimasequestri; un sequestro organizzato da Leonardo Tomasi; con Federico Giaime Nonnis, Daniele Podda, Leonardo Tomasi e un ostaggio; dramaturg Sonia Soro; consulenza linguistica Francesco Cappai. Marco Montecatino, Banned – Tutorial per Boomer; regia e drammaturgia Marco Montecatino; con Angelica Bifano, Renato Bisogni, Giuseppe Brunetti, Claudia D’Avanzo; progetto sonoro Gino Giovannelli. Pietro Giannini, La costanza della mia vita; di e con Pietro Giannini. RI.TE.NA. Teatro, ’E Zzimmare; regia e drammaturgia Fabio Di Gesto; con Francesca Fedeli, Luca Lombardi, Marco Munno, Maria Claudia Pesapane, Gennaro Rivetti; drammaturgia musicale Tommy Grieco; scene Mariateresa D’Alessio; costumi Rosario Martone; luci Luca Sabatino. Sea Dogs, Permacrisis; di e con Simone Chiacchiararelli, Giacomo Lilliù, Arianna Primavera, Francesca Zaira Tripaldi; da un’idea di Francesco Bianchi; coordinamento drammaturgico e registico Francesco Bianchi. Tilia Auser, Tre voci; da un radiodramma in versi di Sylvia Plath; direzione, drammaturgia, composizione vocale Sara Bertolucci; disegno sonoro e musiche originali Riccardo F. Scuccimarra; scene Antonino Leocata. Valentina Dal Mas, Luisa; di e con Valentina Dal Mas; tecnica Angela Marangon.
Visti a: Premio Scenario 2023 – 9° edizione, Festival Scenario, Bologna, DAMSLab, 2-3 settembre 2023.
Tutte le foto degli spettacoli sono di Malì Erotico.